|
 Rossoneri comunque Rossoneri comunque
In un libro, edito da Limina, la fede e la passione per il Milan. Venticinque racconti dai tempi di Rocco a quelli di oggi Con tre testimoni d'eccezione: Rivera, Lodetti e Sacchi
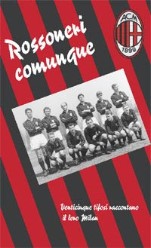
Perché si diventa tifosi e si sceglie
una squadra piuttosto che un'altra? Un plagio paterno? Una ripicca da
scuola elementare o d'asilo? Una questione di colori o un'assonanza di
nomi? Ognuno può dare la sua risposta oppure non trovarne nessuna e
crescere «schiavo» di quella fede senza sapere il perché. Certo è
che poi non si cambia più: almeno per i «fedeli» veri, escludendo
quelli che tifano solo per la nazionale (ridicoli, perché sarebbe come
dire «a me il sesso piace solo la domenica») ed Emilio Fede
(l'eccezione che conferma la regola, anche se lui, in realtà non ha
cambiato squadra - dalla Juve al Milan - ma è passato dal senso di
realtà all'innamoramento per Silvio Berlusconi). La fedeltà alla
maglia è una delle poche coerenze nazionali di un paese che ha fatto la
storia del trasformismo e in cui sono svanite ideologie e appartenenze
di ogni genere: una delle rare costanti italiane. E ogni tifoso, fino
alla fine dei suoi giorni, rimarrà indissolubilmente legato a quella
maglia scelta da bambino; nonostante tutto. Riprova ne è la recente
fioritura di una «letteratura» calcistica fatta di fronteggiamenti
feroci: Rossoneri comunque (Limina
editore, pp. 150, euro 13,50), a cura di Davide Grassi e Andrea Scanzi,
ne è uno degli ultimi esempi. Venticinque fan milanisti raccontano la
propria fede: sono scrittori, giornalisti, musicisti, con il corredo di
tre protagonisti, Giovanni Lodetti, Gianni Rivera e Arrigo Sacchi. E' un
libro fazioso, come tutti i suoi pari, in cui il Milan viene raccontato
attraverso il filo delle memorie personali, tutte accomunate
dall'alternarsi di gioie e drammi di tifosi più o meno famosi, da Enzo
Jannacci a Fabio Treves, da Leonardo Coen a Giulio Nascimbeni, da Franz
Di Cioccio a Mauro Raimondi. Venticinque «giocatori», rosa ampia,
panchina lunga. Tutti ci mettono la propria passione, forse i più
distaccati sono proprio i tre protagonsiti, Lodetti, Rivera Sacchi. Gli
altri si scatenano nella faziosità, soprattutto nella contrapposizione
con i tifosi interisti.
La chiave del libro è quel «comunque», parola che fa pensare a una
vera e propria antropologia milanista. Perché il dato che accomuna
storie tanto diverse è un'appartenenza fondata sulla sofferenza e
l'ostinazione, la fedeltà vissuta più attraverso le dolorose cadute
che fondata sulle gloriose risalite. Quasi che i momenti di gioia
contino meno delle delusioni. Sono le «tragedie» a rinsaldare la fede
calcistica: forse vale per tutte le tifoserie, ma - visti gli estremi
della recente storia milanista - per quella rossonera l'appartenenza in
negativo conta ancor di più.
A cercare una costante di Rossoneri comunque ci si imbatte in un
malinconico orgoglio: la nostalgia per un calcio fatto di radioline
transistor a fronte di pay-tv, posti non numerati allo stadio contro San
Siro che diventa il Meazza post-mondiali `90, eroi popolari versus «calciatori
vetrina»; e, poi, la certezza dello slogan «il Milan siamo noi», non
l'attuale presidente, la cui presenza diventa quasi un fastidio, un'arma
polemica in mano all'avversario, soprattutto se si è - come lo sono
quasi tutti i narratori di questo libro - di sinistra (la fastidiosa e
stupida domanda «ma come fai a tifare per il Milan di Berlusconi?»).
Così le vergogne sportive (la serie B o la «fatal Verona») passano
persino in secondo piano (anzi, diventano motivo di orgoglio nei 60.000
a vedere Milan-Cavese 1 a 2). Ciò che costituisce una vera tragedia è
quel presidente ingombrante, quell'«usurpatore» di cui Giacomo Papi
sogna di smascherare la fede nerazzurra durante un derby. Quello che
tutti (tranne Sacchi) vogliono considerare un episodio di passaggio, da
cui prendere le distanze, come fecero i ragazzi della curva sud, il
giorno della sua «scesa in campo» politica, esponendo uno striscione
con sberleffo di sinistra.
Questa è la sofferenza comune, questo è il Dna del tifoso milanista,
preoccupato dalla contaminazione politica del suo Milan, delle
infiltrazioni nella tifoseria militante del tipo «Commando Tigre», il
gruppo ridotto a guardia pretoriana del presidente, tenuto a distanza da
quelli della Fossa e dalle Brigate e «confinato» nel primo anello di
san Siro, perché il cuore del tifo sta lassù, in piccionaia, nei
vecchi «popolari».
Di fronte alla favola per ricchi di Berlusconi, il tifoso milanista (di
sinistra) si rifugia nel ricordo di Sandro Viola, nel romanzo popolare
di Vincenzina davanti alla fabbrica, nel vecchio «Paron» Rocco, quello
che sapeva vincere gli scudetti con un centravanti come Chiodi, un
mediano come De Vecchi, che sapeva coccolare a modo suo Rivera e far
rinascere dal prepensionamento Sormani o Hamrin (perché è troppo
facile vincere tutto con davanti Van Basten, dietro Baresi e in mezzo
Gullit e Rijkaard). Il vecchio Rocco Nereo da Trieste, che parlava in
dialetto e sdrammatizzava tutto. Quello che all'allenatore avversario
che gli si rivolgeva con un «Vinca il migliore», rispondeva con un
disarmente e fazioso «Speremo de no»: il nostro augurio di oggi - alla
vigilia di Juve-Milan, finale di coppacampioni - che sognamo un gol di
Gattuso all'ultimo secondo, per «rubare» una partita magari brutta ma
combattuta, di quelle che non piacciono al presidente-usurpatore. Perché
sarebbe una vittoria tutta nostra, non sua.
index
|